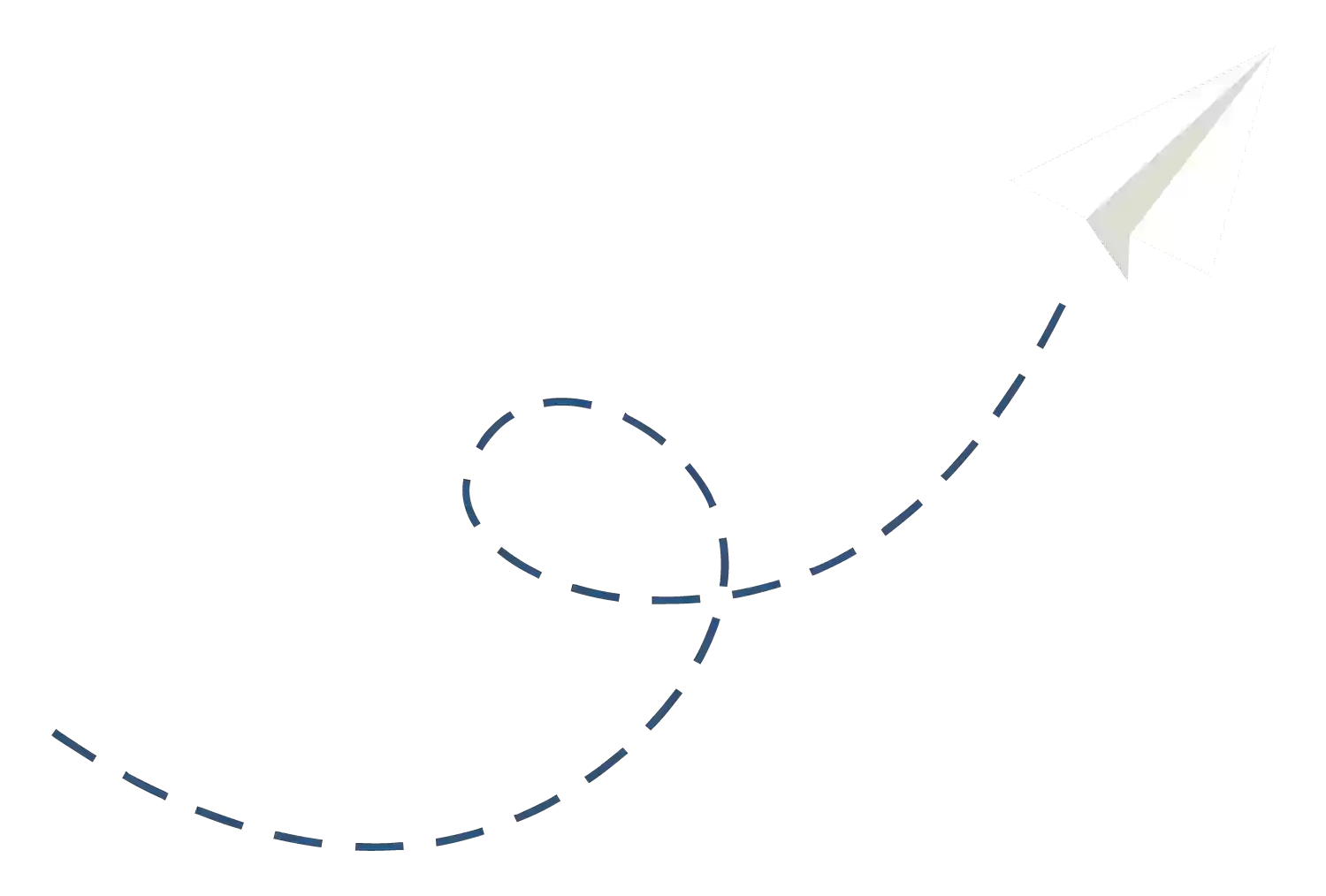Assicurazione contro le calamità naturali:opportunità o nuovo onere per le imprese? Il (possibile) ruolo delle relazioni industriali
| di Sara Prosdocimi
Di fronte all’intensificarsi degli eventi naturali estremi e alle conseguenze sempre più evidenti del cambiamento climatico sul sistema produttivo nazionale, il legislatore è intervenuto con una misura che intende rafforzare la capacità di risposta delle imprese italiane. La Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all’art. 1, commi da 101 a 111, ha infatti introdotto un obbligo assicurativo generalizzato per i soggetti iscritti al registro delle imprese, a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali – come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni – che sempre più frequentemente mettono a rischio la continuità produttiva e la sicurezza dei territori.
L’intento è duplice: da un lato, responsabilizzare le imprese spingendole a dotarsi di strumenti di tutela preventiva; dall’altro ridurre il ricorso a interventi emergenziali di natura pubblica, oggi ancora ampiamente prevalenti nel contesto italiano ma spesso disomogenei e tardivi, al tempo stesso contenendo l’esposizione finanziaria dello Stato nei casi di emergenze naturali gravi.
L’entrata in vigore dell’obbligo di copertura assicurativa, fissata inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, e già posticipata al 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, è stata ulteriormente differita per alcune categorie di imprese dal decreto-legge del 28 marzo 2025 del Consiglio dei Ministri. Nello specifico, il termine è stato posticipato al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese. Per quanto riguarda le grandi imprese, l’obbligo di assicurarsi rimane fissato al 1° aprile, ma nei successivi 90 giorni, non si terrà conto dell’eventuale mancato adempimento dell’obbligo ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, anche in riferimento a quelle destinate a eventi calamitosi e catastrofali. A completamento del quadro, il 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023.
Nonostante i (già) numerosi interventi, molte sono le critiche di imprese e associazioni imprenditoriali: in particolare, si sollevano preoccupazioni riguardo ai costi elevati delle polizze, che potrebbero risultare insostenibili per alcune categorie di imprese, soprattutto quelle di dimensioni medio-piccole, e alle difficoltà di accesso a una copertura adeguata, vista la variabilità dei rischi associati a fenomeni naturali estremi. Inoltre, vi è l’incertezza riguardo alla realizzabilità di un sistema di assicurazione uniforme, che rispetti le specificità territoriali e settoriali, senza penalizzare le realtà produttive più vulnerabili.
Per questo motivo, risulta necessario interrogarsi anche su quale ruolo possano avere le associazioni di rappresentanza e, più in generale, le relazioni industriali nella gestione di questo cambiamento normativo. Infatti, sebbene l’obbligo assicurativo rappresenti un avanzamento verso una maggiore responsabilità sociale e ambientale delle imprese, richiede (anche) un cambiamento culturale e organizzativo per evitare che venga percepito solamente come un peso burocratico o economico. È proprio in quest’ottica che le parti sociali possono contribuire in modo determinante a facilitare il dialogo tra imprese, assicuratori e istituzioni, affinché le misure adottate siano efficaci e in grado di rispondere alle reali esigenze del sistema produttivo, garantendo al contempo la sostenibilità economica delle imprese e l’attenzione agli aspetti sociali.
Il nuovo obbligo assicurativo per le imprese: oggetto, destinatari, sanzioni
L’obbligo introdotto dalla legge riguarda i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale delle imprese, come previsto dall’art. 2424 del Codice civile, primo comma, ulteriormente specificati dall’art. 2 del decreto n. 18. Si tratta, quindi, di immobili, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre che di altri beni materiali di proprietà dell’impresa, che costituiscono elementi essenziali per lo svolgimento dell’attività produttiva.
Un elemento essenziale per la piena applicazione del nuovo obbligo assicurativo è rappresentato dalla definizione dei rischi che devono essere oggetto di copertura. È sempre il decreto n. 18 all’art. 3 che fornisce una puntuale descrizione dei fenomeni naturali da considerare rilevanti ai fini dell’obbligo, elencando in modo specifico le tipologie di eventi che rientrano nella copertura obbligatoria. Tra questi, vengono espressamente indicati i fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, considerati “singoli eventi” anche quando causati da precipitazioni atmosferiche di elevata intensità e di durata specifica, assumendo questi dettagli un rilievo fondamentale per l’applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro. Oltre ai fenomeni di natura idrogeologica, l’art. 3 del decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 estende l’ambito della copertura assicurativa anche ad altri eventi naturali caratterizzati da un elevato potenziale distruttivo e, in particolare, i terremoti, purché i beni si trovino in aree individuate tra quelle interessate dal sisma sulla base dei provvedimenti emanati dalle autorità competenti e localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e le frane. Un aspetto rilevante del quadro normativo delineato riguarda l’assenza, nell’elenco degli eventi coperti obbligatoriamente, degli incendi.
Il nuovo obbligo assicurativo si applica a un ampio spettro di soggetti: sono tenute a rispettarlo, in primo luogo, le imprese con sede legale in Italia, nonché le imprese con sede legale all’estero, a condizione che operino tramite una stabile organizzazione sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2188 del Codice civile. In base all’ordinamento vigente, sono obbligati all’iscrizione gli imprenditori che esercitano: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (come il commercio all’ingrosso o al dettaglio); un’attività di trasporto via terra, acqua o aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti. L’art. 2200 Codice civile dispone, altresì, che “sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V – vale a dire le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata comprese quelle semplificate – e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale”. Rientrano nel perimetro dell’obbligo anche le società tra professionisti, qualora iscritte al Registro delle imprese. Restano invece escluse, in quanto non soggette a tale iscrizione, le imprese agricole, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 111, della legge 213/2023. La norma, dunque, adotta un criterio oggettivo e formale di inclusione, basato sull’iscrizione nel Registro, indipendentemente dalla forma giuridica assunta o dal settore specifico di attività.
La normativa consente una certa flessibilità nella definizione dei contenuti delle polizze assicurative, prevedendo la possibilità di una franchigia, cioè una quota parte del danno non indennizzabile, a condizione che tale scoperto non superi il 15% del complessivo (comma 104 dell’art. 1 della legge 213/2023); nonché una proporzionalità del premio assicurativo al livello di rischio, con l’applicazione di criteri differenziati in relazione a fattori come la localizzazione geografica dei beni, la vulnerabilità degli impianti, la tipologia delle attività produttive e la storicità degli eventi catastrofali in determinate aree.
Ulteriori specificazioni in merito alla franchigia e ai massimali di indennizzo sono contenute negli artt. 6 e 7 del decreto n. 18. In particolare, l’art. 6 stabilisce che, per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, la franchigia eventualmente prevista nel contratto non possa comunque superare la soglia già definita del 15% del danno accertato. Qualora la somma assicurata ecceda i 30 milioni di euro, è ammessa la possibilità di applicare ulteriori scoperti o franchigie, purché pattuite tra le parti e comunque nel rispetto dei limiti generali di proporzionalità e trasparenza previsti dalla normativa di settore. L’art. 7, invece, disciplina i massimali di indennizzo, che devono essere chiaramente indicati nel contratto di assicurazione e calibrati in modo da garantire una copertura coerente con il valore effettivo dei beni assicurati. La norma prevede una disciplina differenziata in base al valore dei beni assicurati, suddivisa in tre livelli. Per beni con un valore inferiore a 1 milione di euro, non c’è limite massimo all’indennizzo, che copre quindi integralmente il danno subito. Per valori tra 1 milione e 30 milioni di euro, è possibile un limite all’indennizzo, ma non inferiore al 70% del valore assicurato. Per valori superiori ai 30 milioni di euro, il limite massimo di indennizzo è definito con accordo tra le parti, in base al rischio e al valore complessivo dei beni.
Infine, il comma 102 dell’art. 1 della legge 213/2023 disciplina le conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligo assicurativo, stabilendo espressamente che la mancata stipula di una polizza conforme alle disposizioni normative comporta l’esclusione dell’impresa inadempiente dall’accesso a misure di sostegno pubblico, inclusi anche gli interventi straordinari di sostegno previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Il comma 107 invece prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro per le imprese di assicurazione che rifiutino o eludano l’obbligo.
Le criticità del nuovo obbligo assicurativo
L’obbligo assicurativo, pur rappresentando un passaggio significativo nella strategia pubblica per la gestione dei rischi ambientali e la protezione delle imprese contro eventi calamitosi, ha già sollevato diversi dubbi e criticità pratiche (si veda ad esempio, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Polizze per i rischi catastrofali obbligatorie per le imprese, Approfondimento, 10 marzo, 2025). Prima di tutto, l’obbligo coinvolge formalmente tutte le imprese, comprese quelle di piccole dimensioni e le società tra professionisti, per le quali il costo delle polizze potrebbe risultare sproporzionato rispetto alla dimensione e all’esposizione al rischio (si vedano ad esempio le dichiarazioni di Confindustria e la nota di Unimpresa). Inoltre, non è chiaro come le polizze esistenti possano essere integrate con i nuovi requisiti normativi; e ancora, il decreto non fornisce indicazioni chiare sulle modalità di controllo e sanzione, sollevando il rischio che alcune imprese possano minimizzare l’obbligo o addirittura ignorarlo.
Di fronte a questi dubbi e incertezze, non stupisce la richiesta di proroga del termine avanzata da Confindustria così come associazioni datoriali fra cui Assoedilizia e Associazione della Proprietà Edilizia di Milano, per i quali l’introduzione di un termine così stringente, senza un sufficiente supporto interpretativo, porrebbe il rischio di errori con effetti controproducenti, creando incertezze sia per le imprese che per i lavoratori. Il 28 marzo, in risposta a queste richieste, il Consiglio dei ministri ha quindi approvato un decreto-legge che posticipa, come già anticipato, l’obbligo per alcune categorie di imprese di stipulare contratti assicurativi contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Se la proroga è stata recepita con favore, rimane in ogni caso l’importanza di utilizzare i prossimi mesi “per fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo dell’obbligo di assicurazione: beni da assicurare, danni da risarcire, confrontabilità delle offerte delle assicurazioni” (si veda la nota di Confartigianato). Un primo passo in questa direzione è il tavolo convocato per lunedì 31 marzo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme alle Organizzazioni imprenditoriali e Ania, per avviare la risoluzione dei dubbi ancora presenti.
Una nuova opportunità per le relazioni industriali?
In questo contesto, i sistemi di relazioni industriali possono svolgere un ruolo cruciale, adattando e integrando le normative alle nuove necessità emerse dall’acuirsi di disastri naturali e di situazioni di emergenza. Da quanto descritto, risulta infatti ancora evidente una carenza di progettualità nelle fasi di ricostruzione, soprattutto per quanto concerne non solo il ripristino fisico di strutture e infrastrutture, ma anche una riprogettazione strategica che favorisca il rilancio del territorio, dei settori produttivi e delle attività imprenditoriali nonché la necessità di dare attenzione anche agli aspetti sociali, oltre che economici, di tali eventi catastrofici (sul tema si veda M. Giovannone, S. Spattini, L’impatto dell’alluvione su lavoratori e imprese, in Boll. ADAPT, 27 gennaio, 2014). La carenza di attenzione rivolta ai lavoratori coinvolti, che, insieme ad altri gruppi vulnerabili, sono tra i più esposti agli effetti devastanti delle calamità, evidenzia la necessità di un approccio integrato (sul tema, si veda M. Tiraboschi, Prevenzione e gestione dei disastri naturali: sistemi di welfare, tutele del lavoro e relazioni industriali, ADAPT Working Paper, 27 maggio, 2014, n. 157).
Testimonianza di come le relazioni industriali possano operare efficacemente è il contesto del sisma del 2012 in Emilia-Romagna, momento gli enti bilaterali del sistema Confesercenti con Unicredit hanno siglato un accordo che ha permesso alle imprese e ai lavoratori delle zone colpite di accedere a finanziamenti vantaggiosi, favorendo la ripresa delle attività. Questo modello di bilateralità ha dimostrato un impatto positivo, non solo nella fase immediata dell’emergenza, ma anche nella costruzione di un sistema di prevenzione per eventi futuri, evidenziando l’importanza di un dialogo continuo tra imprese e sindacati per garantire la sicurezza e la stabilità del mercato del lavoro nelle aree vulnerabili (per altri esempi sul tema si rimanda a M. Tiraboschi (a cura di), Il ruolo delle relazioni industriali nella gestione delle calamità naturali e dei disastri ambientali – Riflessione sul caso italiano, ADAPT Working Paper, 28 gennaio, 2014, n. 148).
Alla luce di queste esperienze, è evidente come le relazioni industriali possano svolgere un ruolo centrale nella preparazione e nella risposta a calamità naturali, collaborando attivamente con il legislatore, garantendo non solamente la continuità produttiva e la ricostruzione delle imprese danneggiate da disastri ambientali, ma contribuendo anche a tutelare maggiormente i lavoratori e le comunità locali, rafforzando così la resilienza complessiva delle aree colpite.
Condividi su: