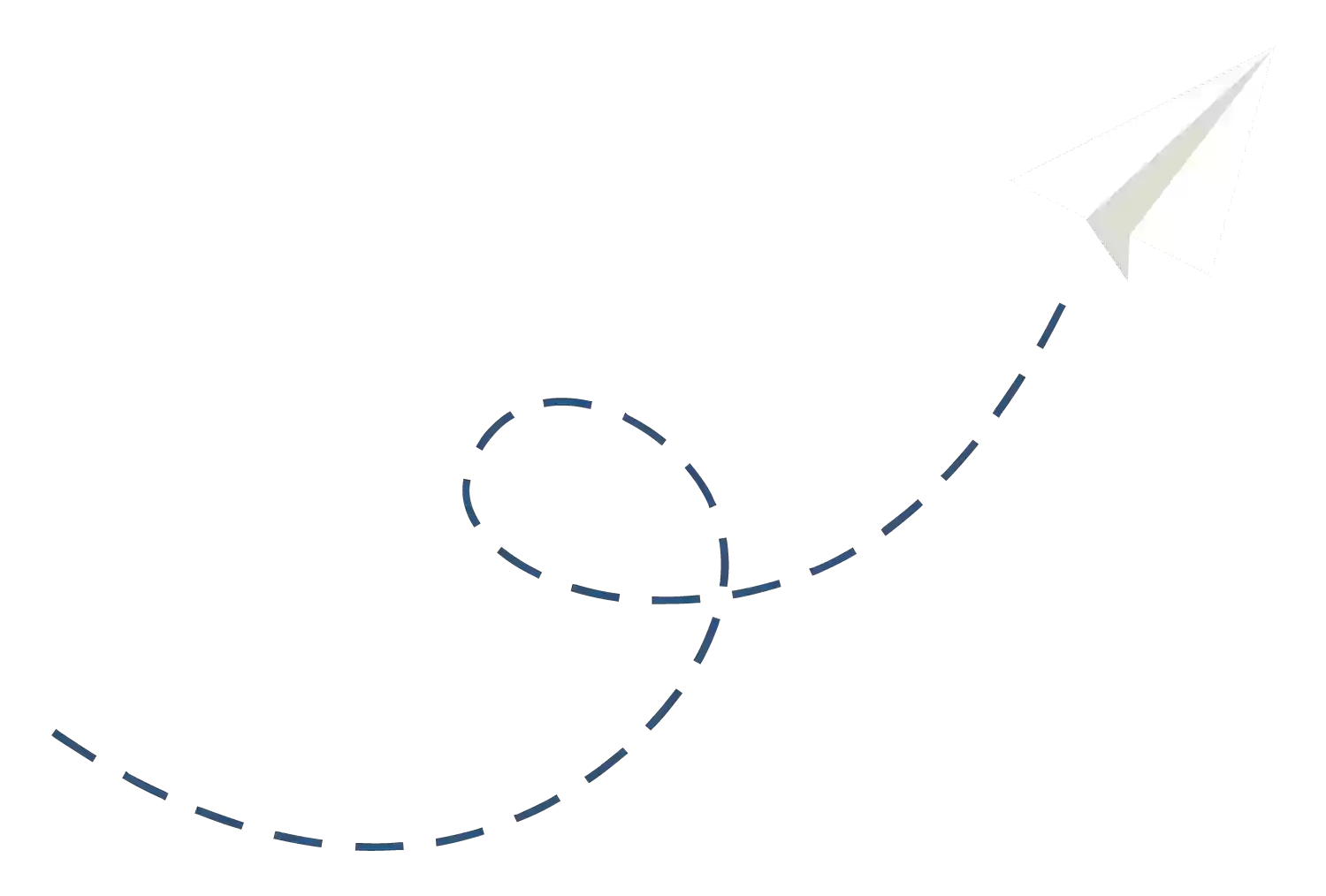Fabbisogni di competenze e twin transition nel settore delle costruzioni: prime evidenze da una rassegna ragionata della letteratura
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro
| di Michele Corti
Il settore delle costruzioni riveste un ruolo centrale nell’economia europea e italiana, sia in termini di occupazione che di crescita produttiva. Negli ultimi anni il comparto ha visto, dopo anni di stagnazione, un significativo incremento del numero di lavoratori impiegati (+450mila circa tra il 2020 e il 2023 secondo Istat), in parte grazie a interventi pubblici come gli incentivi fiscali per la riqualificazione edilizia e in parte grazie i fondi stanziati nell’ambito del PNRR. Questi interventi espansivi, e in particolare il “Superbonus 110%” sono stati oggetto di un ampio dibattito di carattere sia politico che accademico con riflessioni sulla loro efficacia e sostenibilità (si veda, ad esempio, A. ACCETTURO et. al., L‘impatto economico degli incentivi fiscali alle ristrutturazioni edilizie, Banca d’Italia, 2024; L. GARICANO, How to torch 220 billion euros. When the ECB, Brussels, and Markets All Looked Away, 2025). La loro valutazione si inserisce in un contesto in cui il settore delle costruzioni è chiamato ad affrontare, con particolare intensità, le due grandi transizioni del nostro tempo: quella verde e quella digitale. Significativa, poiché, come in altri ambiti e forse ancor più, queste trasformazioni incidono profondamente sulle competenze richieste ai lavoratori, modificandole in un settore caratterizzato da alta frammentazione e complessità. Ad esempio, il settore è caratterizzato da una larga maggioranza di imprese piccole o micro, con meno di 20 dipendenti (sono il 94,3% a livello italiano secondo Istat, 2024), e l’incidenza del lavoro irregolare era pari, nel 2022, al 12,5% (Istat, L’economia non osservata nei conti nazionali, 2024).
Questo contributo, dunque, vuole offrire alcuni dati e spunti di riflessione organizzati in nodi tematici, utili a comprendere meglio gli impatti generati dalle trasformazioni gemelle nel settore delle costruzioni con specifico riferimento ai fabbisogni formativi emergenti, e alle possibili strategie disponibili per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di competenze e profili professionali strategici. Nei paragrafi seguenti, perciò sono illustrate le evidenze preliminari su questi temi, per come illustrate dai principali contributi scientifici e di letteratura grigia raccolti, sistematizzati e analizzati attraverso la metodologia della literature review[1].
È utile partire da alcuni dati: a livello nazionale la quota di lavoratori con più di 50 anni è raddoppiata dal 2004 al 2020, passando dal 18% al 36% nel 2020 (CRESME, Il lavoro nelle costruzioni: la sua immagine, sempre meno giovani, la mancanza di lavoratori, 2024), mentre il 55,5% di essi risulta possedere come titolo di studi più elevato quello ottenuto a completamento della scuola dell’obbligo. Queste evidenze rinforzano l’impressione che uno degli aspetti cruciali per favorire il successo di questa duplice transizione sarà, inevitabilmente, l’equipaggiare i lavoratori, nuovi e vecchi, con le giuste competenze. Il settore delle costruzioni soffre di un forte skill mismatch, con una carenza di lavoratori qualificati in ambiti come la gestione dei dati, la progettazione digitale e l’implementazione di soluzioni sostenibili, ma anche le competenze più strettamente tecniche e di “cantiere” risultano di difficile reperimento. A livello europeo, entro il 2035, si prevede che saranno necessari oltre 4 milioni di nuovi lavoratori per sostituire quelli che lasceranno il settore, in un importante ricambio generazionale. Il ritmo ed il livello di formazione e aggiornamento professionale non sembra però, al momento, essere sufficiente per accompagnare questa transizione (Cedefop, Construction workers: skills opportunities and challenges, 2023).
Principali innovazioni e fabbisogno di competenze
Ma quali sono le principali innovazioni che la duplice transizione ha già introdotto nel settore? Dal punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale, il termine sostenibilità è da intendere come linea guida trasversale a tutte le fasi di vita di un edificio, dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla costruzione alla ristrutturazione. Due sono i driver fondamentali in questo senso: l’adozione di pratiche di economia circolare (E. GASPARRI et al., Circular economy in construction: A systematic review of knowledge gaps towards a novel research framework, 2023) e l’impiego di materiali sostenibili (European Commission, Principi dell’UE per le materie prime sostenibili, 2021). Con riferimento invece alla transizione digitale, le novità possono essere ricondotte ad un framework che integra tecnologie ordinabili in uno schema tripartito di cui fanno parte innovazioni tecnologiche legate strettamente alla produzione industriale come prefabbricazione, stampa 3D, assemblaggio e produzione offsite; Cyber Physical Systems che includono robot e cobot per lo svolgimento di processi ripetitivi e/o pericolosi, droni per rilievi, sollevamento, movimentazione e posizionamento e attuatori; tecnologie digitali come i modelli BIM, BEM e DIM scansione video e laser, IoT, sensori, intelligenza artificiale e cloud computing, big data e analisi dei dati, acquisizione della realtà, blockchain, simulazione, realtà aumentata, standard di dati e interoperabilità, integrazione verticale e orizzontale.
Le indagini sui fabbisogni di competenze a livello settoriale indicano che per gestire questa transizione l’attenzione non si dovrà limitare alle sole competenze tecniche legate alle nuove tecnologie, ma anche su un insieme di capacità trasversali che supportano la sostenibilità e l’adattabilità in un contesto in continua evoluzione (A. VAN HERDEEN et. al., A Study of the Soft Skills Possessed and Required in the Construction Sector, 2023). Le competenze tecniche rimangono centrali, soprattutto quelle connesse alle tecnologie emergenti per l’efficienza energetica, la digitalizzazione dei processi e le pratiche costruttive sostenibili. Tuttavia, secondo la letteratura emergente, a differenza del passato, quando le cosiddette soft skills venivano considerate superflue, un’eccessiva focalizzazione su questi aspetti rischia di trascurare la complessità dei cantieri moderni, dove diviene fondamentale una comprensione integrata delle normative ambientali e delle strategie di gestione delle risorse. A livello europeo, le stime prevedono che da qui al 2035 la quota di lavoratori in possesso di competenze di medio livello, corrispondenti ai livelli 3 o 4 dell’ISCED, rimarrà pressoché invariata e vicina al 60%, mentre aumenteranno di 10 punti percentuali i lavoratori in possesso di qualifiche elevate (ISCED 5 o superiore) e diminuiranno sensibilmente coloro in possesso di qualifiche di basso livello ( ISCED 1 e 2) (Cedefop, Construction workers: skills opportunities and challenges, 2023).
La formazione tra giovani, divario di genere e aggiornamento delle competenze
Per affrontare queste sfide, è necessario un approccio integrato che combini politiche pubbliche, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze. La collaborazione tra istituzioni educative, imprese e organizzazioni del settore può favorire la creazione di percorsi formativi più adatti alle esigenze del mercato del lavoro. Gli ITS Academy, ad esempio, rappresentano un modello efficace per formare professionisti altamente qualificati nel settore edile, colmando il divario tra formazione accademica e competenze pratiche richieste dalle imprese, formando grazie a percorsi formativi flessibili e dinamici profili ibridi in grado di raccordare con successo la fase di progettazione e quella operativa, di “cantiere”. Alla piramide demografica nazionale non può però che accompagnarsi il bisogno, inevitabile, di intervenire in modo massiccio anche dal punto di vista dello sviluppo continuo delle competenze lungo l’arco della carriera lavorativa. Un’azione, peraltro, i cui effetti positivi sono ampiamente documentati, sia dal punto di vista dei benefici economici che sociali, nel settore delle costruzioni (che soffre di un invecchiamento particolarmente accentuato della forza lavoro) come in senso più ampio (R. ANGOTTI et. al., The renewed role of continuing vocational training for inclusion and territorial development in the twin transitions, INAPP, 2022). Le azioni altamente targetizzate, attraverso una formazione modulare e riconosciuta, basata su micro-credenziali e offerta in modo tempestivo, hanno dimostrato di poter favorire un miglior raggiungimento degli obiettivi formativi e di inserirsi con efficacia nel contesto settoriale. Esempi di successo sono stati individuati nei programmi BIMcert and ARISE, finanziati nell’ambito di Horizon 2020 (A. BEHAN et. al. Skills Matter – up-skilling across construction stakeholders for emerging roles, 2023).
Anche l’inclusione di genere rappresenta una sfida importante. Attualmente, la presenza femminile nel settore delle costruzioni è estremamente bassa, attestandosi intorno al 12% nell’intera filiera e al 7% nei cantieri (Federcostruzioni, La presenza femminile nel mondo delle costruzioni, 2024). In assoluto, tra i valori più bassi, anche se tra il 2019 e il 2023 le lavoratrici nel settore, anche grazie alle nuove competenze richieste dalle transizioni in atto ed ai vincoli sulle assunzioni introdotti, sono aumentate del 34,7% (Camera dei Deputati, L’occupazione femminile, 2023). Nonostante ciò, uno dei principali ostacoli all’ingresso delle donne nel settore rimane la percezione negativa condizioni di lavoro: orari impegnativi, ambienti di lavoro poco accoglienti e una cultura ancora fortemente maschile rappresentano barriere significative. Inoltre, molte lavoratrici riportano esperienze di discriminazione di genere e comportamenti inappropriati nei cantieri, che rendono ancora più difficile la loro permanenza nel settore.
In conclusione, il settore delle costruzioni si trova, sia per quanto riguarda la transizione digitale, sia per ciò che concerne la transizione verde, di fronte a una trasformazione senza precedenti. L’adozione di nuove tecnologie e pratiche sostenibili sta ridefinendo le competenze richieste, rendendo necessario un investimento massiccio nella formazione professionale e nell’aggiornamento continuo dei lavoratori. Ciò comporta evidentemente sfide significative, a fronte un forte disallineamento tra le competenze disponibili e quelle richieste, un significativo e progressivo invecchiamento della forza lavoro e una scarsa partecipazione femminile. La collaborazione tra istituzioni educative, parti sociali e attori pubblici sarà cruciale per garantire una transizione efficace, creando percorsi formativi più adatti alle esigenze del mercato e valorizzando le competenze trasversali necessarie in un contesto in continua evoluzione. Solo attraverso un approccio strategico, multilivello e partecipato sarà possibile rendere il settore più competitivo, inclusivo e sostenibile nel lungo periodo.
Michele Corti
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
 @michele_corti1
@michele_corti1
[1] La rassegna ragionata della letteratura è in corso di finalizzazione ed è stata sin qui implementata nell’ambito della prima fase della rilevazione prevista della Linea A (rilevazione del fabbisogno di competenze e profili professionali) condotta da Fondazione ADAPT all’interno del Patto per le Competenze e per l’Occupazione in Lombardia per il Settore delle Costruzioni (CUP: E84G24000110007), coordinato da ANCE Lombardia.
Condividi su: