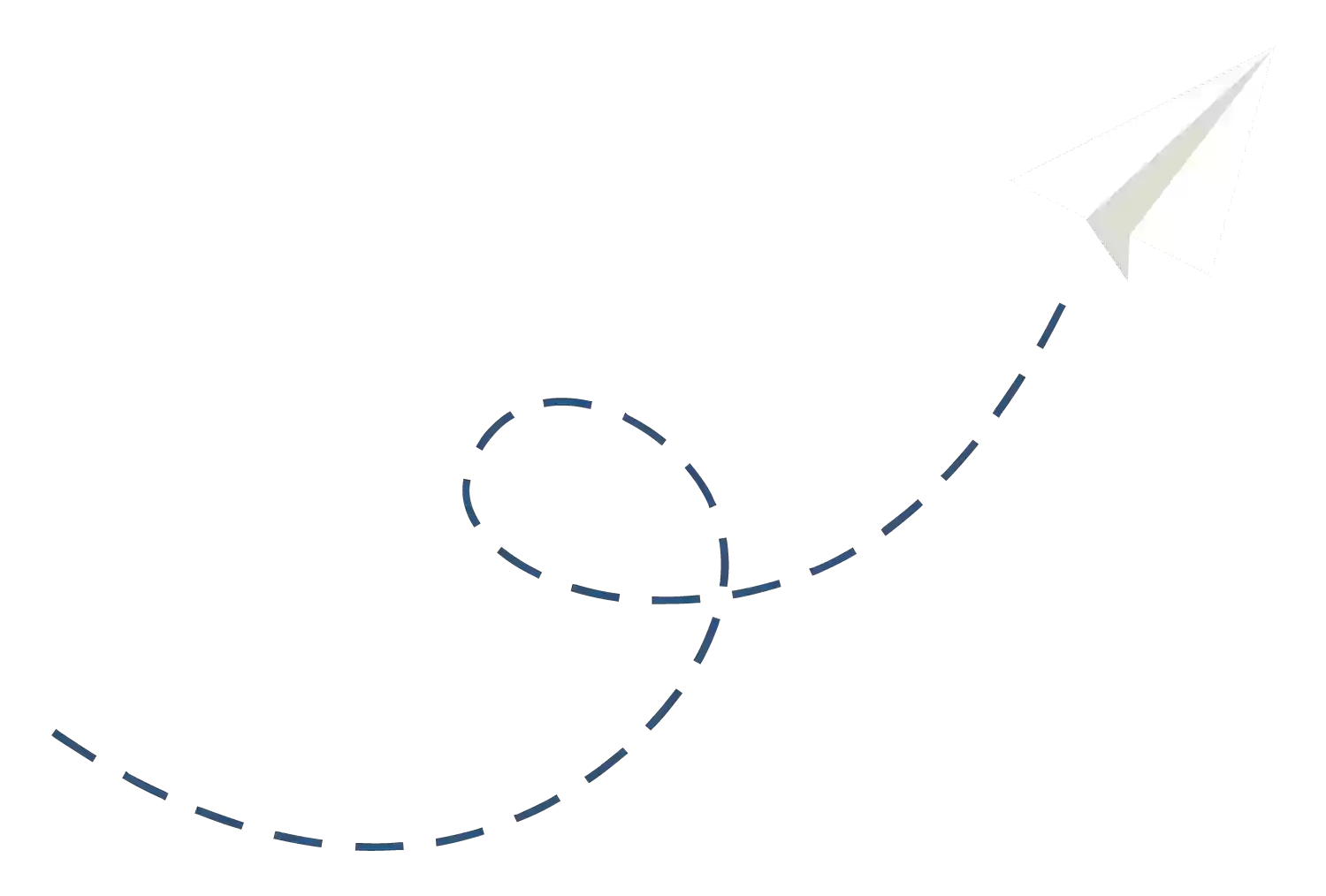Nuove e vecchie prospettive per il tempo di lavoro
Bollettino ADAPT 7 aprile 2025, n. 14
Quello del tempo di lavoro è un tema particolarmente attuale nel dibattito pubblico dove sta tornando fortemente sia nella sua declinazione quantitativa (il dibattito sulla riduzione dell’orario di lavoro) sia in quella qualitativa (il suo ruolo nell’organizzazione del lavoro). Anche per questo motivo, e per non rischiare di approcciare il tema in modo superficiale e contingente, senza cogliere le implicazioni profonde ad esso connesse, sarebbe utile rileggere il saggio “Work, Time and Industry” scritto dall’antropologo Tom Ingold e pubblicato nel 1995. Nel testo l’autore aiuta ad afferrare la natura di uno strumento come l’orario di lavoro e il suo ruolo e impatto nella società occidentale. Innanzitutto riprende la teoria secondo la quale sarebbe possibile distinguere due diversi sistemi di organizzazione delle società: il primo, tipico delle società preindustriali, che definisce task-oriented, in cui il tempo non era rigido, misurato in unità fisse come ore e minuti, ma seguiva il ritmo della natura e delle attività umane, la persona era al centro e ciò che accadeva non veniva identificato sulla base di riferimenti temporali, ma in relazione ad altri accadimenti; e il secondo sistema, quello “dell’orologio”, che nasce con l’avvento del capitalismo industriale e separa il tempo di lavoro dal tempo di non lavoro, è estrinseco alle relazioni sociali e confina la persona ai margini dell’organizzazione industriale della produzione. In questo secondo sistema il soggetto è considerato perennemente in oscillazione fra il lavoro, come attività pubblica, e il consumo, come attività privata.
Nelle società preindustriali le persone organizzavano il proprio lavoro in base a fattori ambientali, stagionali e comunitari e, per esempio, il lavoro degli artigiani (falegnami, fabbri, tessitori), era orientato alla qualità del prodotto piuttosto che alla velocità di produzione, ogni pezzo veniva realizzato con attenzione, senza la pressione costante del tempo. O ancora, molte attività lavorative erano integrate nella vita quotidiana e familiare, senza una rigida distinzione tra “tempo di lavoro” e “tempo libero”. Le persone lavoravano secondo necessità e non secondo turni imposti. Le attività “lavorative” erano un tutt’uno con le attività “sociali”, non c’era una distinzione possibile tra questi due ambiti. La divisione della vita era basata sulle diverse attività che in un continuum si svolgevano.
Con l’industrializzazione, questa organizzazione del tempo viene stravolta. L’introduzione di orari fissi e turni imposti dalle fabbriche in quanto funzionali ai nuovi processi produttivi, trasforma il lavoro in un’attività separata dalla vita personale e sociale, creando la distinzione tra tempo di lavoro e tempo libero. La produttività diviene il principale obiettivo, portando alla standardizzazione delle mansioni, che si compie poi con l’adozione del taylorismo, e alla perdita di controllo individuale sul proprio tempo. Per Ingold, questa trasformazione ha avuto conseguenze profonde sulla percezione del tempo e sul modo in cui le persone vivono il proprio rapporto con il lavoro, rendendolo più rigido e meno armonioso rispetto al passato.
Secondo i più le società occidentali avrebbero superato la prima impostazionein favore della seconda, mentre altre società, non ancora pienamente industrializzate, sarebbero rimaste alla prima. La posizione dell’autore, invece, è che questo passaggio non si sia verificato fino in fondo nemmeno in Occidente, poiché in diversi ambiti della vita umana persiste una organizzazione del lavoro basata non sull’orologio, bensì sulle necessità della vita. Questa prospettiva è supportata dal caso emblematico del lavoro domestico e di cura, le cui dinamiche sono resistenti all’ingresso del capitalismo, poiché strutturalmente connesse alle variazioni umane e quindi poco inclini a adattarsi alla rigidità dei tempi di produzione.
L’aspetto più interessante e attuale della posizione di Ingold, prescinde però dal caso specifico del lavoro domestico e di cura e porta ad interrogarsi in generale sulle moderne tendenze organizzative e sulla praticabilità – e eventuali implicazioni – di un modello task oriented, non del tutto scomparso, nell’ambito dell’economia capitalista.
Quando Ingold parla di task orientation intende “task” come «attività integrata in una relazione sociale» (p. 6), che viene svolta in qualità di soggetti appartenenti ad una rete di rapporti più o meno articolata e non come “lavoratori” avulsi dal contesto sociale di appartenenza. L’attività nel senso inteso da Ingold non può essere svolta dalla macchina, perché implica una consapevolezza, anche rispetto agli obiettivi e al contesto, che a suo avviso solo l’umano può esprimere. Questo grado di integrazione fra l’attività e la dimensione sociale e comunitaria è possibile nella misura in cui il soggetto manifesta la propria identità anche – se non primariamente – attraverso l’attività che svolge e lo fa da proprietario della capacità di lavoro che esprime.
Seguendo le categorie offerte da Ingold quindi, la possibilità di emanciparsi progressivamente da un’organizzazione del lavoro basata sull’ora-lavoro industriale per favorire una maggiore autonomia del lavoratore, è quindi fortemente legata all’adozione di una nuova prospettiva sul lavoro, come attività intrinseca e non estrinseca alla vita. In questo senso tornare alle origini dell’introduzione dell’orario di lavoro e alle sue implicazioni risulta particolarmente interessante in un momento storico in cui si discute di una progressiva retrocessione di questo strumento a vantaggio di modalità di organizzazione del lavoro basate più sugli obiettivi e risultati raggiunti che sulla misurazione dell’ora-lavorata.
Il testo qui analizzato aiuta a comprendere come tale trasformazione sia complessa, in particolare alla luce della natura del rapporto fra la persona che lavora e la sua attività, portando ad interrogarsi sulle possibili configurazioni che tale rapporto può assumere nel quadro dell’economia capitalista. Da qui una spiegazione plausibile del fatto che in poche aziende è possibile riscontrare davvero la realizzazione di un moderno modello task-oriented o, almeno, uno stadio avanzato di transizione. Occorrerebbe infatti tornare a un’idea di lavoro che, pur innestandosi nel contesto di un’economia capitalista nella quale la produttività e il profitto sono obiettivo primario, sappia riconciliarsi con i ritmi di vita senza perpetuare una cesura tra questi due aspetti.
Il tema non è quello del ritorno ad una attività lavorativa che procede in parallelo con i ritmi della natura, ma di avere strumenti organizzativi che consentano un nuovo modello task-oriented nel quale vi sia maggior autonomia di gestione del proprio lavoro, sconnettendola, per quanto e dove possibile, dal fattore tempo e tentando – in questi termini – una riconnessione fra persona e lavoro. Ciò significa mettere in discussione alcuni dei fondamenti che hanno guidato l’introduzione dell’orario di lavoro, primo tra tutti il controllo e la piena disponibilità, relativamente alle funzioni connesse al lavoro, delle persone in determinati periodi di tempo. E per farlo occorre introdurre categorie differenti di responsabilità e di fiducia, parole che già da sole ci suggeriscono l’entità della sfida che abbiamo di fronte.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
Presidente ADAPT
Condividi su:
Ultimi Interventi
Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/267 – Rinnovo...
di Silvia Caneve, Fulvio Cucchisi, Arianna Ferraguzzo, Giorgia Martini, Marco Menegotto, Giuseppina Papini, Erika Rizzi, Jacopo Sala