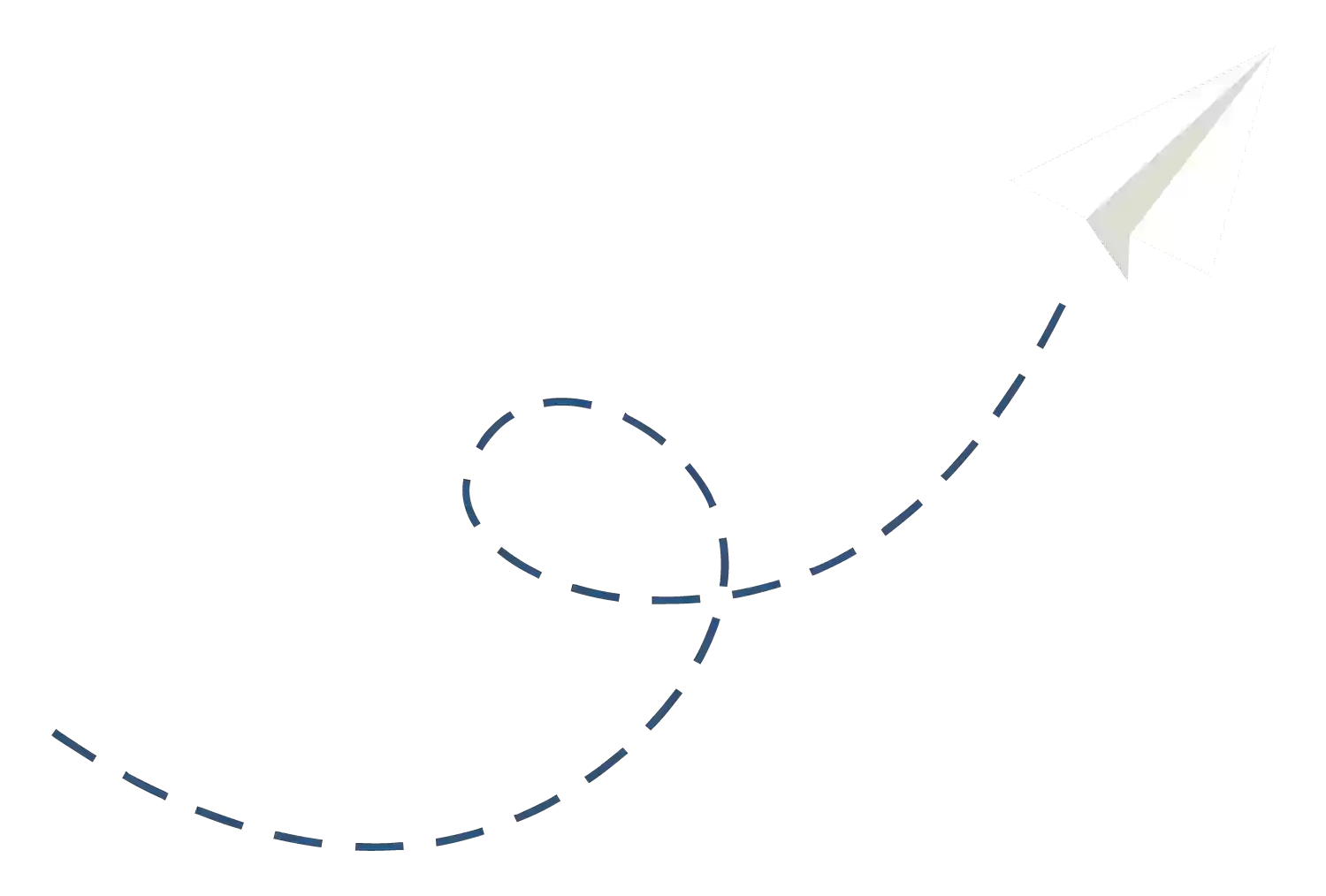Politically (in)correct – Chi trasforma lo sciopero in una pagliacciata non può erigersi a strenuo difensore del diritto
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Emmanuele Massagli

Bollettino ADAPT 20 novembre 2023, n. 40
Se non lo avessero ancora fatto consigliamo a Maurizio Landini e a Pierpaolo Bombardieri di andare insieme a vedere il film – opera prima per la regia – di Paola Cortellesi: “C’è ancora domani”. E di prestare attenzione al colloquio tra il padre invalido e Ivano il marito manesco (nervoso perché ha combattuto ben due guerre) di Delia, la protagonista. Il padre rimprovera il figlio per le frequenti percosse alla moglie per futili motivi. Ma le rimostranze paterne non sono rivolte ad incutere nel figlio, peraltro già adulto da tempo, l’idea del rispetto dovuto ad una persona vicina. Infatti, la moral suasion non invita a non picchiare la donna neppure con un fiore, ma a percuoterla duramente una volta ogni tanto, come faceva lui con la moglie; perché se le botte sono troppo frequenti finisce che Delia “si abitua” e non ci fa più caso. Può essere che questo episodio del film induca i due Cavalieri dell’Apocalisse a chiedersi se anche gli italiani si siano abituati alla routine degli scioperi generali durante la sessione di bilancio, con una particolare propensione per la giornata del venerdì (posso testimoniare che Bruno Trentin, giustamente superstizioso, non avrebbe mai proclamato uno sciopero di venerdì 17).
Ormai sono scioperi che somigliano ogni anno di più ad autodafé di carattere politico, non solo per i motivi alla base dell’astensione dal lavoro, ma anche per le propensioni di chi aderisce. Le rivendicazioni sindacali si concentrano su obiettivi generici, buoni per tutti gli utilizzi, denunciano un malessere di carattere generale, in modo che gli scioperanti possano gettare nel falò delle manifestazioni, sempre meno oceaniche (anche se sono diventate il parametro della riuscita dell’iniziativa perché nessuno è più in grado di avere dei dati minimamente affidabili sulle assenze dal lavoro) la fatica quotidiana di vivere delle loro famiglie unitamente all’avversione per la maggioranza e il governo in carica. In breve lo sciopero generale – sia pure con una mano di vernice economica – ha una netta motivazione politica che è poi la stessa ad essere condivisa dai lavoratori aderenti.
Dello sciopero del 17 novembre si è parlato e si parla unicamente per la piega politica che hanno assunto gli eventi. Il casus belli è sorto a seguito delle osservazioni (assolutamente corrette e conformi alla legge e alla giurisprudenza) dell’Autorità garante. Probabilmente, in una circostanza diversa le cose si sarebbero chiarite senza troppi problemi. Ma come potevano Cgil e Uil lasciarsi scappare l’occasione per accusare il governo di voler attaccare i sindacati e ledere il sacrosanto diritto di sciopero? Esiste o no l’intenzione di una svolta autoritaria che dopo essersi manifestata attraverso l’autonomia differenziata, il premierato, è arrivata al caposaldo della democrazia, il diritto di sciopero? Ed ecco il primo vero atto eversivo: l’accusa alla Commissione di garanzia di aver preso ordini dal governo.
Delegittimare il Garante è stata un’azione gravissima, condotta in modo disonesto, perché non si va a saccheggiare i curricula dei cinque commissari, mettendo in dubbio la loro credibilità (per uno di essi, il sospetto nasceva persino dall’essere stato collaboratore di Marco Biagi) per presunte simpatie con la destra. Quando i cinque esperti del CNEL – pur non essendo una componente, ma tante persone singole – hanno votato insieme ai rappresentanti di Cgil e Uil sul documento per il salario minimo, nessuno è andato ad esplorare nelle loro vite. E se lo avesse fatto sarebbe stato crocefisso in sala mensa. Lo stesso si può dire di tanti giudici costituzionali (anche assurti al ruolo di presidente) che hanno avuto trascorsi definiti in politica e nei rapporti con la stessa Cgil.
Sul versante opposto non ci si poteva aspettare che Matteo Salvini non approfittasse dell’inciampo giuridico capitato ai sindacati per assumere il ruolo di Capitan Fracassa, non già allo scopo di difendere il governo che non sentiva il bisogno di essere difeso (Giorgia Meloni ha dato allo sciopero lo scarso rilievo che meritava), ma per presentarsi all’opinione pubblica e all’elettorato di destra come l’intemerato giustiziere degli abusi dei sindacati nei confronti degli inermi cittadini, lasciandosi andare a considerazioni e battute non opportune per un ministro. Ma, come in algebra, due comportamenti scorretti di segno opposto si elidono. A proposito di questa Grande Pagliacciata ha scritto su Tempi, Emmanuele Massagli: “La vicenda è preziosa per tornare a riflettere del rapporto tra sindacato e politica. Il motivo del contendere, infatti, non è la difesa del diritto di sciopero (di certo non messo in dubbio da nessuno), né le gravi conseguenze della legge di bilancio sui lavoratori e i pensionati (anzi, pare vero il contrario: sono queste categorie ben più tutelate dalle proposte del Governo rispetto ad aziende, liberi professioni o giovani, solo per fare degli esempi), bensì l’affermazione di una visione solo politica della realtà.
Vale per Landini, che questo sciopero lo ha annunciato già a luglio, quando neanche esisteva una bozza di legge finanziaria, perché per definizione bisogna essere contro a un Governo di centro-destra, come per Salvini, che sa di ricompattare il proprio bacino elettorale polemizzando con i sindacati’’. Ma “in un momento di trasformazione socio-economica come quello attuale, nonché di instabilità inflazionistica e geopolitica, l’Italia – prosegue Massagli – ha bisogno che i sindacati (e non “il sindacato”) tornino ad elaborare proposte concrete sul lavoro, non slogan buoni per ogni tempo; a incontrare le persone una a una, oltre che in piazza; ad essere punto di riferimento e compagno di strada per chi lavora, ad ogni livello, in ogni settore, con qualsiasi contratto. Così facendo il sindacato reciterà anche un ruolo politico originale e prezioso, non certo scimmiottando i partiti politici’’. Il bello è che mentre in Piazza del popolo i due tribuni della plebe evocavano le solite catastrofi, il rating dell’agenzia Moody’s, a sorpresa, promuoveva l’Italia, nonostante – alla faccia del ritorno all’austerità – che il bilancio preveda un indebitamento netto programmatico pari a -4,3% del PIL nel 2024, -3,6% nel 2025 e -2,9% nel 2026, a fronte di un debito pubblico che potrebbe da un momento all’altro caderci addosso come la Garisenda.
Membro del Comitato scientifico ADAPT
Condividi su: