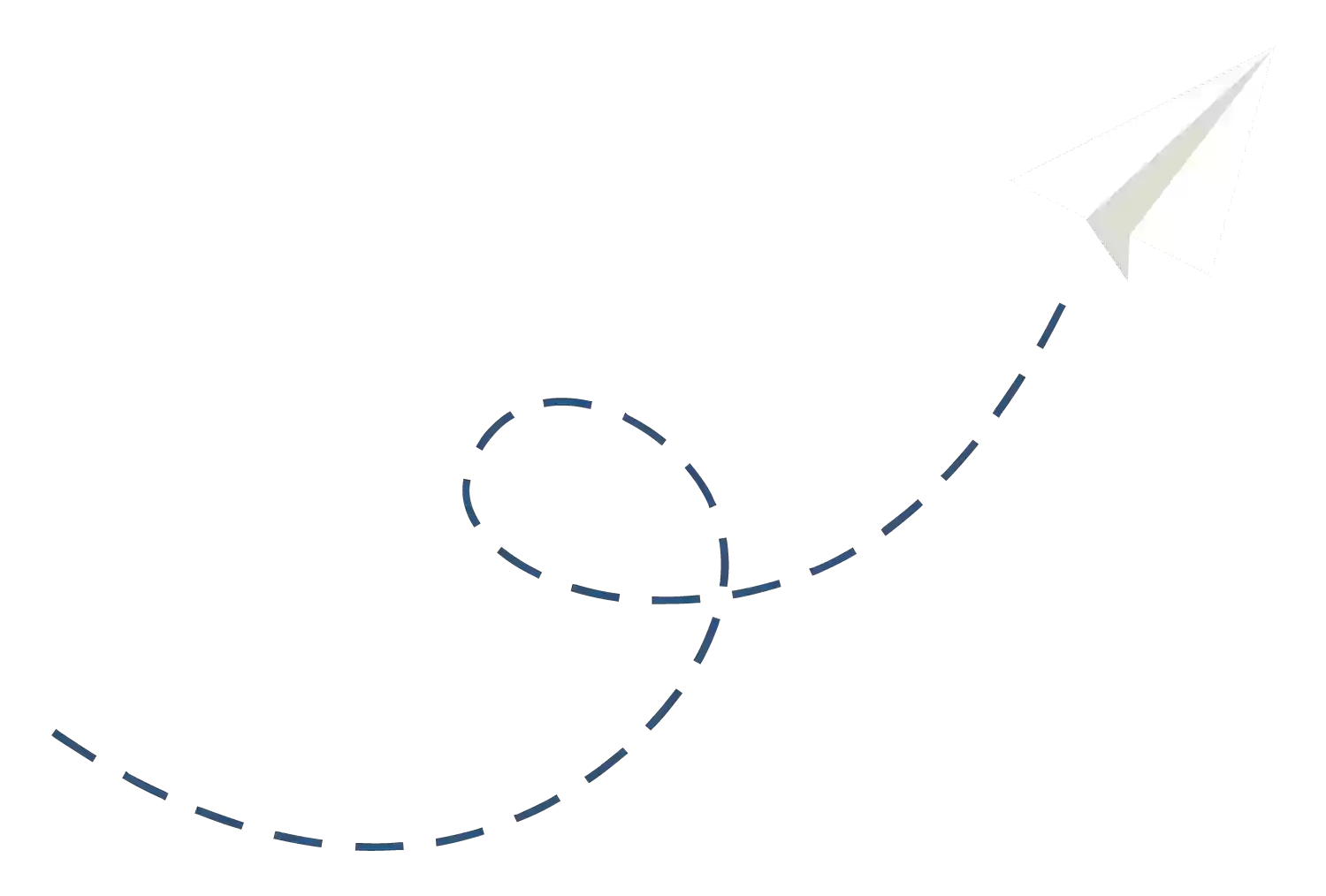Prime riflessioni pedagogiche a riguardo del nuovo progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro, Salute e sicurezza
| di Emmanuele Massagli
ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it
Bollettino ADAPT 20 maggio 2024, n. 20
L’approvazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» è una buona notizia. Di certo sono diversi gli elementi di criticità che permangono e che dovranno essere affrontati, ma è indubbio il passo in avanti. Si può discutere sull’ampiezza della falcata, ma non sulla coerenza tra questo atto e la dichiarata volontà di consentire alla persona con disabilità «il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione» (articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, contenente la delega esercitata nel decreto del 3 maggio).
Le novità, numerose e rilevanti, in materia di definizione della condizione di disabilità e accomodamento ragionevole sono segnalate nel contributo di Maria Paola Monaco e Vincenzo Falabella ospitato in questo stesso bollettino. In questa sede si vogliono invece presentare alcune prime valutazioni a riguardo delle nuove disposizioni in materia di «progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».
Una regolazione per il progetto di vita
Il primo spunto è suggerito dalla sola ricomprensione nel testo di questo istituto. Fino ad oggi la definizione legislativa di «progetto di vita» è stata piuttosto sfumata. Non vi sono riferimenti diretti in leggi dello Stato, se non nel D.P.R 12 ottobre 2017 recante «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità», ove si legge che «per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine».
Meno vaghe, ma non ancora esattamente definitorie, le indicazioni contenute nella prassi del Ministero dell’Istruzione: si vedano tra le altre le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate nel 2009. Qui si legge che il PEI deve tenere conto del «progetto di vita» della persona e che «è nella definizione del progetto di vita che si realizza l’effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali all’inclusione scolastica e sociale» (p. 11). Più preciso il paragrafo 1.4 della terza parte del documento: «il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell’innalzamento della qualità della vita dell’alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l’orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l’orientamento, le possibili scelte che l’alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica» (p. 16).
Quanto si legge nel Capo III del decreto legislativo del 3 maggio completa le intuizioni appena riportate, dandone dignità legislativa.
La novità più significativa è da ricercarsi nella coscienza che un percorso di inclusione riuscito non può accontentarsi di accompagnare la persona solo in un tratto importante, ma relativamente ristretto, della vita (la scuola), né può avvalersi soltanto di alcune figure professionali senza coinvolgere tutti i servizi e attivare tutte le risorse del territorio. Come si dice nelle aule di pedagogia speciale (in LUMSA all’argomento è dedicato un laboratorio intero nell’ambito dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno): il progetto di vita è una attività (più che un documento burocratico, quale è invece il «progetto individuale», seppure tra le novità vi sia anche la formalizzazione di questo percorso in un dossier a cui è associato anche un budget) necessariamente inclusiva, che ha come fine l’innalzamento della qualità della vita dell’alunno con disabilità (ma ogni persona, invero, ha un proprio progetto di vita!), anche attraverso la predisposizione di percorsi extra-scolastici, lavorativi e sociali. Lo si legge all’articolo 18, comma 2: «Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali». Così operando, «il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi» (art. 19, comma 1).
Personalizzazione e partecipazione
Il secondo spunto è invece suggerito dal cambio di denominazione, che ha acquisito le parole «individuale personalizzato e partecipato». Il nome di questa “attività” ne risulta un po’ appesantito in termini comunicativi, ma raffinato sotto il profilo del significato. Il legislatore si è mosso nella direzione prospettata dalla letteratura pedagogica (si pensi alla proposta di «progetto di vita personalizzato inclusivo» contenuta in Canevaro, Gianni, Callegari, Zoffoli, L’accompagnamento nel progetto di vita inclusivo, Erickson, Trento, 2021). Il percorso è «personalizzato» perché al centro vi sono le esigenze, i desideri, i talenti e la condizione della singola («individuale») persona con disabilità (si ricordi che la “personalizzazione” è il superamento in chiave soggettiva della “individualizzazione”, che è dimensione collettiva); è «partecipato» sia perché ne è protagonista la persona stessa, non di certo ridotta ad “utente”, sia perché coinvolge tutti gli attori sociali perché siano correttamente considerati tutti gli aspetti distintivi dell’adultità e dell’autonomia, citati tra gli obiettivi di intervento all’articolo 26: «1) apprendimento, socialità ed affettività; 2) formazione, lavoro; 3) casa e habitat sociale; 4) salute». In questo senso, la valorizzazione della “partecipazione” in luogo della “inclusione” appare centrata: un processo di coinvolgimento che attiva sia la persona che la comunità che gli è intorno, superando l’equivoco di una “inclusione passiva” che finisce per essere solo formale.
È proprio questa la sfida dei prossimi anni, ora che è stato approvato il d.lgs. 62/2024: impegnarsi perché ciò che è ivi contenuto non rimanga sulla carta, come troppe volte accaduto in materia di disabilità, ma diventi esperienza viva di valorizzazione di tutte le persone, quale che sia la condizione di salute.
Emmanuele Massagli
Presidente di Fondazione Ezio Tarantelli – ADAPT Senior Fellow
 @EMassagli
@EMassagli
Condividi su: