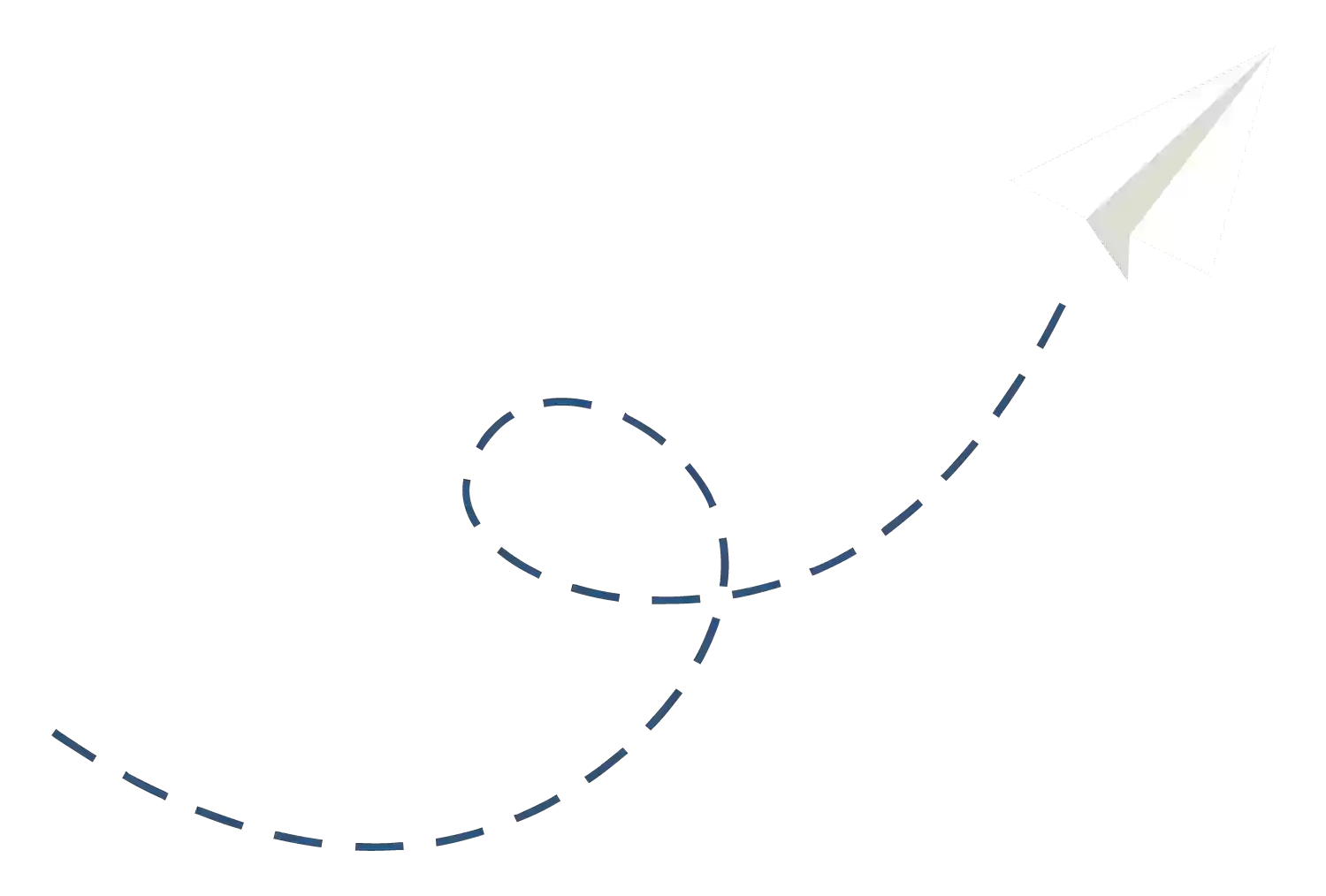Rileggendo Marco Biagi: un lavoro di rilettura per comprendere l’attualità del suo pensiero
Bollettino ADAPT 24 marzo 2025, n. 12
In vista dell’evento del 18 marzo presso il CNEL, intitolato “Rileggendo Marco Biagi. Lettura di alcuni saggi di Marco Biagi in materia di politiche occupazionali e del lavoro, anche nella prospettiva del raccordo tra formazione e lavoro” (visibile qui), la Scuola di Alta Formazione di ADAPT ha promosso un’attività preparatoria, partecipata da ricercatori, dottorandi, apprendisti e talenti di ADAPT, dedicata alla rilettura di alcuni testi selezionati del Professor Biagi. Questo lavoro ha consentito di approfondire i contenuti che sarebbero poi stati oggetto di discussione durante l’evento, grazie all’analisi di testi pubblicati tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000 ed elencati di seguito:
– Biagi, Università e orientamento al lavoro nel doporiforma: verso la piena occupabilità?, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3, 2002, pp. 343-356;
– Biagi, Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 3, 2001, pp. 257-289;
– Biagi, Formazione e qualità: note per una strategia comunitaria dell’occupazione, in Diritto delle relazioni industriali, n. 2, 1996, pp.75-83;
– Biagi, M. Tiraboschi, La rilevanza della formazione in apprendistato in Europa: problemi e prospettive, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1, 1999, pp. 85-116.
Con riferimento al tema dell’università e all’orientamento al lavoro, uno degli stimoli più importanti, all’interno del percorso di rilettura, è stato fornito dalla definizione dell’evoluzione dell’università da «un sistema economico e sociale di tipo “industrialista” di dominio (quasi) esclusivo dell’apparato tecnico-produttivo» ad un sistema nuovo «fondato sulle conoscenze» a cui doveva seguire un ripensamento complessivo del rapporto tra università, società civile, istituzioni e tessuto produttivo locale per evitare la senescenza del sistema universitario e fare in modo che gli attori di quest’ultimo potessero dare il meglio di sé. A queste considerazioni si aggancia anche la visione di collegare l’università al mondo del lavoro, per il tramite dei tirocini pensati, a differenza di quanto accade oggi, come uno strumento concreto di formazione pratica e di placement lavorativo.
Tra gli spunti di riflessione dell’incontro al CNEL, è emerso come Biagi si fosse posto subito il problema dell’evoluzione tecnologica, della lentezza di cambiamento dell’università, della perdita del monopolio della conoscenza da parte di quest’ultima e la perdita del monopolio della produzione da parte delle aziende.
Oltretutto, è stata considerata anche la preoccupazione, da parte di Biagi, della mancanza di formazione interdisciplinare, di capacità innovative e di flessibilità proprie del settore ICT e la volontà di realizzare un raccordo operativo tra imprese, istituzione universitaria ed enti locali introducendo veri e propri uffici placement, con la creazione anche di patti locali per la piena occupabilità al fine di valorizzare le potenzialità formative ed occupazionali in aderenza alle vocazioni produttive dei territori.
A distanza di venticinque anni, quanto sognato da Biagi si è realizzato non completamente nelle università, ma come ricordava Alfonso Balsamo (Advisor Education, Confindustria) nell’ambito dell’evento citato tanto più nei percorsi delle ITS Academy che conoscono benissimo i concetti di placement, orientamento, occupabilità, flessibilità, vocazioni produttive e accordi con imprese e parti sociali. La più grande peculiarità degli ITS è che al loro interno insegna (anche e soprattutto) chi fa impresa, e si caratterizzano per una forte coerenza tra percorso formativo offerto e successivo inserimento lavorativo. In sostanza, questi percorsi rappresentano, ad oggi, l’esperimento pratico di quanto prospettava Biagi nei primissimi anni duemila.
È stato inoltre ricordato da Balsamo come, in tema di formazione universitaria e orientamento al lavoro le azioni da intraprendere debbano essere: comparare, riformare e seminare. Solo con il confronto dei modelli, la volontà di riforma e l’integrazione nel nostro sistema di ciò che è diverso si può spingere l’università e la formazione in generale verso una coerenza tra formazione e lavoro.
Per quanto concerne la formazione e la qualità, in ottica progettuale, Biagi prospettava la necessità di superare un modello incentrato esclusivamente sul conseguimento di titoli, privilegiando invece lo sviluppo delle capacità e mirando alla formazione per competenze e non per qualifiche, come ricordato da Marina Mobiglia (Avvocato, Clifford Chance) nel suo intervento al CNEL.
Questo “saper fare” già prospettato da Biagi si collegava poi alla possibilità di ottenere una validazione delle proprie competenze professionali, acquisite anche in contesti non formali e informali, superando la tradizionale separazione tra luoghi di apprendimento (scuola e università da una parte, azienda dall’altra) e sui certificati in uscita, alla luce piuttosto di una formazione riconosciuta come di qualità. Al riguardo, è emerso anche come lo scopo ultimo della formazione, infatti, debba essere la promozione della persona e delle pari opportunità come strumento per superare le varie segmentazioni del mercato del lavoro, proprio in ottica di quanto prospettava Biagi e cioè, che una formazione determinata unicamente dalla domanda di mercato, è capace di generare squilibri economici, soprattutto nelle aree più fragili del Paese.
Il tema della formazione professionale continua a riproporsi nel percorso di rilettura dei testi del prof. Biagi, accendendo il confronto su quello che ancora oggi – così come emerso sia nel corso dell’evento al CNEL, sia nell’ambito di quanto discusso nella Scuola di ADAPT – sembra essere un istituto giuslavoristico dai caratteri e dalle finalità (ancora) poco chiari: l’apprendistato.
L’apprendistato di cui parla il professor Biagi insieme al professor Tiraboschi, è l’apprendistato di fine anni 90, al tempo vittima di una forte decrescita che, allora come ora, era determinata da una pluralità di fattori quali: una domanda superiore all’offerta, la recessione economica, l’introduzione di forme contrattuali concorrenziali rispetto all’apprendistato, quale ad esempio il contratto di Formazione e Lavoro. Biagi analizza l’istituto dell’apprendistato in Europa, in un’ottica internazionale e comparata, e lo presenta quale strumento di accesso al mercato del lavoro. Egli evidenzia in primis l’esistenza di una regolamentazione diversificata fra i Paesi del nord (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito), e i Paesi latini rispetto alla disciplina dell’apprendistato.
Nei primi veniva posto l’accento su quella che è la vera finalità dell’apprendistato, mentre i secondi, compresa l’Italia, hanno incentrato nel corso degli anni la propria legislazione e le proprie iniziative sull’utilizzo dello strumento dell’apprendistato come strumento volto allo sviluppo dell’occupazione e non – concetto fondamentale che poi viene ripreso alla fine del saggio – della occupabilità.
Sicuramente uno dei nodi che caratterizzano ancora oggi l’apprendistato, e che Biagi metteva in evidenza già al tempo, così come emerso durante la rilettura grazie anche al puntuale intervento del dott. Danilo Papa (Direttore generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro) è il tema della funzione impropria attribuita al contratto d’apprendistato. Spesso la funzione prettamente formativa del contratto d’apprendistato, in grado di consentire lo sviluppo della professionalità e dell’occupabilità della persona, è stata soppiantata da funzioni che nel saggio vengono definite di “controllo sociale” o di “sostegno indiretto al sistema produttivo”, quali ad esempio le agevolazioni contributive e fiscali alle imprese e quant’altro. In tal senso la risposta data da Biagi, attuale ancora oggi, è proprio quella di cercare di percorrere la strada di una vera formazione, quello che è stato poi l’obiettivo principale di molte legislazioni del nord Europa, e quindi quella di insistere sul concetto di occupabilità.
Altro punto del testo di Biagi sul quale il dott. Papa si è focalizzato nel corso della rilettura è quello della necessità di adeguare i percorsi formativi, essenza dell’apprendistato, alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Questo è emerso essere un tema fondamentale anche oggi: il consentire all’istituto un rimodellamento veloce non statico proprio per rincorrere le necessità del mercato del lavoro, e da qui la necessità di una semplificazione del quadro normativo, di una maggiore flessibilità da parte della contrattazione collettiva ed anche una riforma delle politiche attive e passive.
Infine altro punto di grande valore dello scritto di Biagi e di grande attualità odierna è il grosso spazio da concedere alle parti sociali. Sul punto, in chiusura del suo intervento, il dott. Papa ha riletto un passo del saggio di Biagi, in tal senso rivelatore: «Come l’esperienza passata insegna, solo il concorso delle parti sociali può` rendere infatti possibili e praticabili quei percorsi di riforma globale del sistema formativo e del diritto del lavoro che, diversamente, verrebbero a trovare insuperabili ostacoli tanto a livello di ingegnerie istituzionali che di relazioni industriali».
A chiudere questo proficuo percorso di rilettura dei testi del prof Biagi va in ultimo citato un saggio del 2001 con cui Biagi desidera far riflettere sulla necessità di ripensare il sistema giuslavoristico italiano partendo in primis da una rivisitazione del modo di concepire e disciplinare il rapporto di lavoro in Italia, al fine di ridargli centralità nel nuovo contesto economico-produttivo di carattere globale.
Biagi rimarca concetti quali il bisogno di flessibilità, di semplificazione del sistema regolatorio e più in generale di sburocratizzazione della materia giuslavoristica. Anche in questo caso, così come nel precedente scritto sull’apprendistato, egli pone l’accento sul ruolo centrale che in questo processo di modernizzazione devono ricoprire le parti sociali, nello specifico attraverso la contrattazione di maggiore prossimità.
Nel proficuo dibattito sviluppatosi all’interno delle attività di approfondimento condotte dalla Scuola è emerso come gran parte delle riforme prospettate dal professor Biagi si siano, anche se solo parzialmente, realizzate. Una di queste riforme, rimasta ad oggi forse la più irrealizzata, ha catalizzato l’attenzione del dibattito, vista forse la sua estrema attualità, e riguarda un tema che Biagi affronta già nel 2001 e che è forse oggi uno dei nodi più problematici nel panorama giuslavoristico italiano, vale a dire la necessità di ripensare lo Statuto dei lavoratori, e per diretta conseguenza la tutela del lavoratore, uscendo dai rigidi canoni della dicotomia lavoro dipendente – lavoro autonomo.
Biagi immagina un nucleo ristretto di principi e norme inderogabili da applicare a tutti i lavoratori, al di là della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e dopodiché prospetta un sistema a geometrie variabili, dove la definizione della specifica tutela, associata a un peculiare tipo di rapporto di lavoro dai canoni non standardizzati, sia ad appannaggio dell’autonomia collettiva ed individuale.
Ciò che con chiarezza è emerso tanto nel dibattito interno alla Scuola, quanto in sede di rilettura all’evento del 18 marzo grazie ai preziosi ed arricchenti interventi dei relatori che vi hanno preso parte, è che temi attuali come quello della formazione professionale, del bisogno di ridare centralità al concetto di occupabilità piuttosto che a quello di occupazione, di ripensare il sistema giuslavoristico italiano in un’ottica di maggiore dinamicità e flessibilità ed ancora di rinnovare e riqualificare il ruolo delle parti sociali nell’intricato sistema odierno di relazioni industriali, sono questioni sulle quali il professor Marco Biagi rifletteva già più di vent’anni fa.
I suoi quattro scritti, appena riletti, testimoniano l’urgenza che il professor Biagi sentiva nel dover affrontare le summenzionate tematiche, ed appaiono come un faro, che per lungo tempo abbiamo avuto a disposizione, su dei problemi passati e presenti ed al contempo una ispirazione per delle soluzioni che, negli anni successivi alla pubblicazione dei suoi lavori, sono state tardivamente adottate ed alcune sono ancora proprio da percorrere.
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
Condividi su: